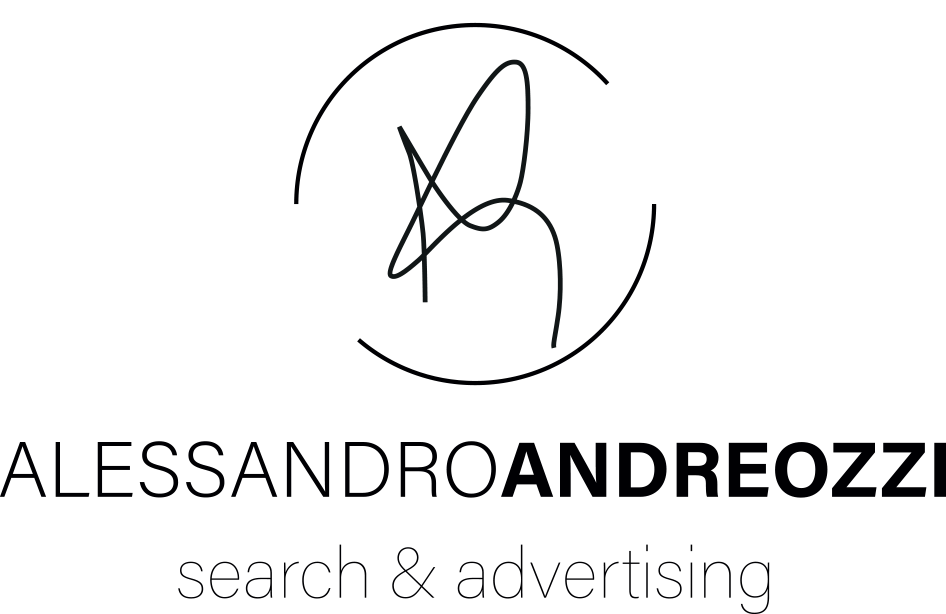
Andreozzi Alessandro
…Dopo un bel pò di tempo e tantissimi clienti, ho capito che l’approccio verso il mondo social, quella che viene definita dai ben pensati come la transizione digitale, in Italia, non è ancora avvenuta. Siamo davvero in alto, alto mare. Il commerciante, che vuole affacciarsi a questo mondo conosce poche cose e per lo più sbagliate. Siamo davvero messi male. E noi (non tutti, ma molti) professionisti, ci mettiamo il carico con promesse mirabolanti ed effetti speciali. Nel 90% dei casi poi, le cose non andranno come previsto e la colpa sarà:….del tempo, troppo caldo, della guerra, del covid, della congiunzione astrale, e via via dicendo con una sequela di scuse che in realtà nasconde un verità purtroppo sempre più emergente…..PROFESSIONALITA’= 0%…
E alla fine, anche per chi lavora da anni in modo etico, professionale e con tanta passione, capite bene che diventa un bel problema !!
6 Punti essenziali che devi considerare quando parli con me...
Serietà
+++ Quando prendo in mano un business, ci metto sempre tutto il mio impegno e la massima attenzione per trovare soluzioni adatte e soprattutto che portino vantaggi. Se percepisco che il mio lavoro non porta vantaggi, sono il primo a fermarmi e fartelo notare !!
Realtà
+++ Quando propongo una azione di marketing ad un mio cliente, gli propongo sempre una azione che farei anche per me. Sono fortemente legato alla realtà. e un mio grande difetto è che dico sempre quel che penso senza filtri..
Ads/Adv
+++ Io non sono convinto che l'unico modo per fare business sia con le sponsorizzate(campagne a pagamento sui social o su Google). Partecipo a progetti (e ho diversi casi studio) dove la parte organica già da sola satura il mercato potenziale. Ma..., questo a patto che ci siano attività esterne che già spingono verso il tuo prodotto / brand. Per cui torniamo sempre lì, per fare business serve budget !!!..E cosa fondamentale...TUTTI vogliono diventare famosi, NESSUNO vuole sacrificarsi per diventarlo !!..Se sei disposto a lavorare duro, crederci, lavorare duro, e crederci, allora arriverai sicuro al 100%. Non ho alcun metodo magico o ricetta segreta, o trucco segreto per aggirare l'algoritmo (l'ultima cagata che ho letto). Il mio e un metodo semplice e scientifico..Si chiama LAVORO..Costante serio e nel tempo. E fidati, non te lo vogliono dire, ma è l'unico metodo, i soldi a pioggia io non li ho mai visti !!
Azione
+++ .." se non tu...chi...se non adesso..quando" Ho sempre pensato in questi termini, serve sicuramente autodeterminazione e voglia di fare..I risultati alla fine arrivano !! Ma prima di tutto bisogna crederci, e se non sei il primo tu a crederci, poi non puoi chiedermi di crederci (IO)
Brutte Notizie
+++ Purtroppo c'è una verità assolutamente ineluttabile. Per fare business serve budget. Non si esce da questa situazione di dualità..Senza facciamo solo due chiacchiere...Immagina di essere in un negozio, un conto è se ti dico che la mela è buona, un'altro è comprare la mela..Da me le mele si comprano !!!
Per capirci meglio....
+++ Recentemente, ho lavorato all'immagine pubblica di un esponente politico per le elezioni europee. Affacciandomi in un mondo davvero strano e singolare dove tutto è il contrario di tutto. Personalmente ho lavorato come ho sempre fatto, testa bassa, tante idee, tanta tecnica, e tanta voglia di imparare. I risultati sono stati eclatanti. Cosi ho messo in cascina anche questa esperienza comprendendo fra l'altro i limiti del mio ragionamento verso un mondo che non conoscevo. Ecco, al mio cliente ho portato il resoconto e i risultati della mia attività. Io non ero molto soddisfatto, Lui era decisamente entusiasta. Cosi ho semplicemrnte detto quello che pensavo e di cui sono certo al 100%. Del lavoro svolto abbiamo si e no sfiorato il 10%, si poteva fare molto di più e molto molto meglio....ECCO IO LAVORO COSI !!!
Se hai letto tutto fino a qui vuol dire che hai un problema e cerchi una soluzione…
…Forse posso aiutarti, ma per farlo ho bisogno di vedere il tuo business, ho bisogno di capire come ragioni,. quali sono i tuoi punti di contatto verso il tuo marketing, Ho bisogno di analizzare la tua concorrenza o quantomeno di capire chi sono quelli che percepisci come concorrenti. Solo dopo saprò dirti se posso esserti d’aiuto in modo proficuo…Tieni presente che se tu non guadagni dalla mia attività neanche io guadagno…Ma nulla nella vita e’ scontato…
Ricorda, in genere per la salute vai dallo specialista, il medico generico ti può aiutare ma fino ad un certo punto..Ma anche lo specialista pur bravissimo nel suo settore specifico, prima ha bisogno di esami clinici a portata di mano e solo poi potrà dirti come curarti, e sempre e comunque con un margine di errore..E il marketing, è proprio come il corpo umano, una cura adatta a te, non lo è per me…Rifletti su questo e in bocca al lupo !!
"Senza dati oggettivi,è solo l'ennesima opinione..."
Non Lasciarti intortare dal guru di turno, a te servono dati oggettivi...numeri veri. Numeri per te e non numeri di un'altro che forse potranno chissà mai il caso, a culo essere pure i tuoi....Se ti stanno fottendo te ne accorgi subito...Ragiona con la tua testa e con il tuo portafoglio...SEMPRE
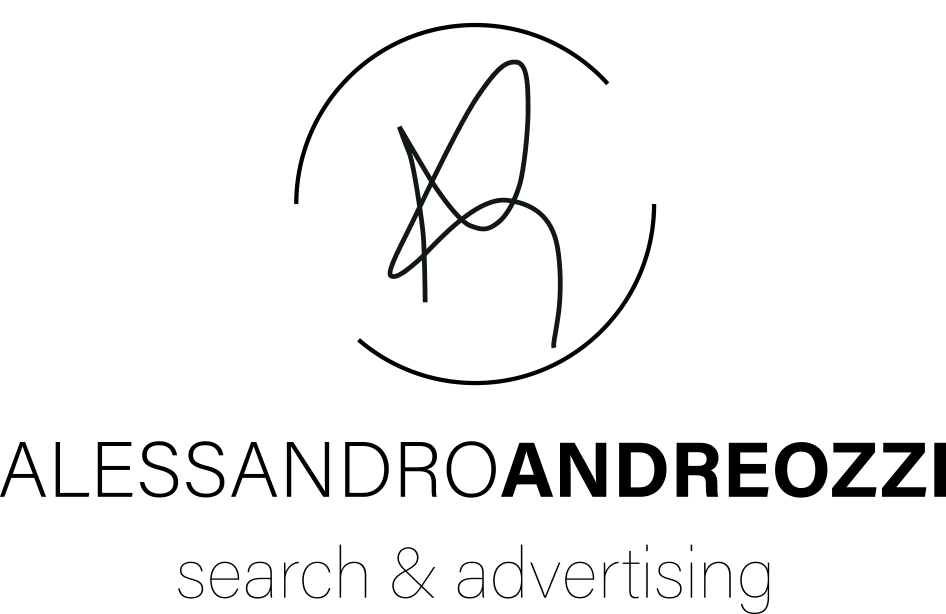
Andreozzi Alessandro
Via Monterotondo, 16 Civitanova Marche (MC)
![]() + 39 347 82045026
+ 39 347 82045026
P.iva : 02036630438
consulenza@andreozzialessandro.it
